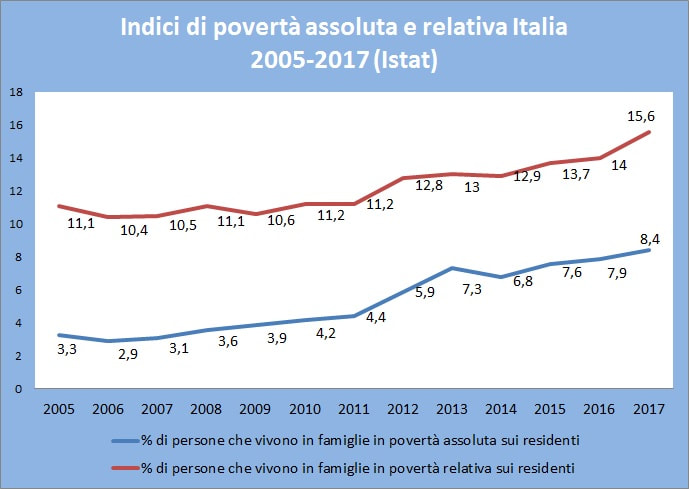
E insomma. I dati pubblicati ieri dall’Istat sulla povertà in Italia nel 2017 ci hanno addolorate ma non stupite: 10 anni ininterrotti di crisi non potevano non avere un impatto devastante sui più deboli: la povertà è infatti aumentata come non mai dal 2005, soprattutto tra i meridionali, gli stranieri, i giovani, gli anziani, gli stranieri, le famiglie numerose. Due numeri veloci:
- 5 milioni e 58 mila individui sono in povertà assoluta, l’8,4% della popolazione (erano il 7,9% nel 2016), dei quali 1 milione 208mila minori. La povertà assoluta degli individui aumenta soprattutto nel Mezzogiorno, dal 9,8% a 11,4%, e nei centri e nelle periferie delle aree metropolitane del Nord. Le famiglie che hanno come persona di riferimento giovani sotto i 35 anni sono in povertà assoluta per il 9,6%, se invece sono anziani over 64 solo per il 4,6%,
- 9 milioni 368mila individui sono in povertà relativa (15,6% nel 2017 contro il 14,0% del 2016). Come la povertà assoluta, la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) o 5 componenti e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di riferimento è un under 35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquattrenne.
Numeri terribili:
possiamo disquisire sulla differenza tra povertà assoluta e povertà relativa ma
pur sempre di povertà parliamo, e i risultati elettorali di questa ultima
tornata elettorale riflettono coerentemente un malessere sociale ed economico
generale che non si limita ai 9 milioni 368 mila di “relativamente”
poveri. La definizione di povertà per l’Istat è infatti strutturata in modo
molto meticoloso su diverse tipologie familiari. Per fare un esempio una
famiglia con due coniugi tra i 18 e i 59 anni e due figli a carico tra i 4 e i
10 anni che vivono in un comune metropolitano del Centro Italia è considerata
in povertà assoluta se ha una capacità mensile di spesa in consumi complessiva
di 1.560,88€ e in povertà relativa se arriva a 1.768,91 €. Ammetterete che le
fasce di popolazione immediatamente superiori a queste soglie non è che
facciano esattamente una vita agiata. Un conto è infatti la definizione
statistica della povertà, un altro è la percezione soggettiva e sociale di
questo fenomeno, che è certamente ben più ampia di questi numeri.
Lo studio Istat ha comunque il merito di fare luce sulla fascia di popolazione
sicuramente più disagiata, per la quale si rendono indispensabili energiche
politiche di welfare e per il lavoro. Dato il numero, far uscire dalla povertà
queste persone avrebbe un impatto macroeconomico importante, non solo in
termini di spesa pubblica per il welfare ma anche di potenzialità lavorative,
fiscali e contributive che si potrebbero sviluppare.
Certo, ci vuole una capacità di governo del welfare che vada oltre la mera
funzione assistenzialista e sappia investire in sviluppo delle capacità delle
persone con una visione e programmazione strategica e soprattutto pluriennale.
Per interventi di sistema è indispensabile però conoscere a fondo la povertà in
tutte le differenze sociali, territoriali, familiari e individuali nelle quali
si articola, poiché occorre dare risposte a bisogni spesso molto differenti tra
loro.
Un aspetto che certamente andrebbe approfondito è la diversa povertà femminile.
Intanto, ci chiediamo: le donne italiane sono più o meno povere degli uomini?
A guardare i dati sul reddito e sulla disponibilità di risorse si direbbe che
sono più povere: le donne guadagnano mediamente a
parità di lavoro 3.000 euro in meno degli uomini, mentre la loro ricchezza individuale è più bassa di
quella maschile del 25%.
Il reddito prodotto autonomamente dalle donne, o le loro proprietà individuali,
rappresentano però indicatori di autonomia e di indipendenza economica.
Diverso è il discorso sulla redistribuzione delle risorse all’interno delle
famiglie, sulla capacità di spesa e di consumo, che definiscono la soglia di
povertà delle famiglie e degli individui. In questo caso le donne, pur essendo
molto spesso dipendenti dalle risorse economiche del partner che mediamente
guadagna di più, godono di una capacità di consumo e di un benessere maggiore
di quello che avrebbero con il loro solo stipendio.
Per questo effetto di redistribuzione delle risorse, del consumo e delle spese
all’interno della famiglia, quindi, il numero delle donne povere a livello
individuale, tra adulte e minori, calcolato dall’Istat sulla capacità di
consumo, non è molto differente da quello degli uomini: dei 5 milioni e 58 mila
di poveri assoluti nel 2017 in Italia 2 milioni 486 mila sono gli uomini e 2
milioni 472mila le donne.
E finisce qui, dai dati Istat del 2017 non sappiamo niente di più sulla povertà
delle donne.
Un po’ poco, no? Altri studi, anche se non recentissimi, ci aiutano invece a
capire in modo un po’ più approfondito le differenti dinamiche della povertà
femminile. Il più completo rapporto sulla
povertà delle donne in Italia risale al 2000 ed è stato prodotto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali
nell’ambito della Commissione di indagine sull’esclusione sociale. Grazie a questa ricerca veniamo così
a sapere che, se per le donne la redistribuzione familiare delle risorse può
apparire un vantaggio, in realtà diventa molto pericolosa perché rappresenta
pur sempre una dinamica di dipendenza: se le cose non vanno bene in famiglia,
se ci si separa o si rimane vedove, aumenta sensibilmente il rischio di povertà
per le donne. Le statistiche ci dicono infatti che il rischio di povertà per le
donne è superiore a quello degli uomini, soprattutto per le fasce di età
relative alla maternità (23,5% contro il 19,9% degli uomini per le 25-34enni,
3,6 punti percentuali di differenza) e soprattutto per le over 75 (18,7% contro
il 12,1% degli uomini, per una differenza di 6,6 punti percentuali).
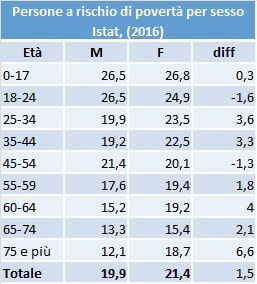
Le donne hanno infatti un tragitto di vita sostanzialmente
differente da quello degli uomini: il loro maggiore impegno nella famiglia
rappresenta un elemento di condizionamento molto forte per le loro possibilità
occupazionali e, quindi corrono un maggiore rischio di povertà non solo in età
adulta ma anche in età anziana.
La povertà delle donne è dunque più complessa di quella maschile, poiché è
determinata da un numero maggiore di variabili di integrazione sociale ed
economica o, viceversa, di esclusione sociale: il lavoro, la famiglia e il
welfare. Per gli uomini, meno condizionati dall’impegno familiare, si può dire
che una volta che c’è il lavoro il rischio di povertà si allontani di molto.
E proprio rispetto a queste tre variabili possiamo considerare come per le
donne alcuni critici eventi della vita possano rendere maggiore il rischio di
povertà: le separazioni, la vedovanza o la malattia possono rappresentare
certamente dei momenti di estrema difficoltà economica.
Più frequentemente rispetto agli uomini, poi, le donne possono perdere o
rinunciare al lavoro per eventi legati alla famiglia: pensiamo alla nascita di
un figlio, alla malattia di un congiunto, alla necessità di assistere un
anziano.
Considerando queste dinamiche vi sono quindi alcuni “target” di donne a
maggiore rischio di povertà, che occorrerebbe studiare di più per poter
intervenire con politiche più mirate ed efficaci. Si tratta ad esempio delle
madri sole, delle donne anziane, divorziate, lavoratrici povere, straniere, in
grave stato di emarginazione o con gravi problemi di salute.
In tutto questo discorso deprimente c’è però un aspetto positivo da mettere in
evidenza: gli studi confermano che le donne, nel momento in cui si trovano in
stato di povertà, hanno delle risorse personali e umane superiori rispetto a
quelle degli uomini per fronteggiare la situazione.
Insomma, tengono più botta.
Direte: grazie. Secoli di sottomissione e inferiorità economica, politica e
sociale ci hanno temprate a sopravvivere a tutto. Beh, è vero, però sono
comunque capacità da non sottovalutare e, semmai, da tenere in considerazione
nella costruzione degli strumenti di contrasto alla povertà.
La maggiore capacità delle donne di affrontare la povertà è legata proprio al
diverso percorso sul quale si forgia l’identità maschile, più legata
all’economia monetaria, rispetto a quella femminile, più frequentemente costruita
sull’economia familiare. Così, quando i soldi scarseggiano, l’identità degli
uomini va inevitabilmente subito in crisi (non guadagno quindi non esisto),
mentre quella delle donne, maggiormente strutturata su altre dimensioni oltre a
quella monetaria, si attiva su altri fronti e si rimbocca le maniche come può e
riesce.
Le donne in stato di povertà si mostrano quindi molto capaci nell’attivare le
cosiddette “risorse non di mercato”. Sanno attivare importanti reti di
relazione, riescono ad utilizzare meglio i servizi dello Stato, trovano
lavoretti nell’economia informale, si impegnano nell’autoproduzione di beni e
servizi e nell’autoconsumo. Il baratto, lo scambio, i vestiti cuciti da sole,
la rinuncia al cibo preconfezionato, alla lavanderia: sono tutte strategie di
sopravvivenza che conoscevano molto bene le nonne che hanno affrontato le
ristrettezze della guerra, ma alle quali si aggrappano ancora oggi le figlie e
le nipoti che stanno cercando di superare la loro “guerra” del nuovo millennio.
Ecco quindi che le donne, più degli uomini, spendono i propri guadagni per la
famiglie e i figli e utilizzano lo stipendio per migliorare l’amministrazione
della casa (Morris, Ruane, 1986), che una sterlina guadagnata dalla moglie ha
maggiori probabilità di essere spesa per i figli di quante ne abbia una
sterlina guadagnata dal marito (Pahl 1989, 1995), che nelle famiglie a basso
reddito è altamente probabile che spetti alle donne la responsabilità di far
quadrare i conti (Taylor-Gooby 1985; McKee, Bell 1985; Fadiga Zanatta, Mirabile
1993; Pahl 1996).
Si combatte, insomma. Certo, è un lavoro immane, per queste donne,
sopravvivere, come lo è d’altronde anche per gli uomini.
Però, voi decisori politici, quando vi metterete seriamente a ragionare su
questi problemi, magari pensateci a queste differenze, che vi potrebbero uscire
anche politiche migliori e più efficaci, sai mai….






